Noi minatori, per la tanta miseria, raggiungevamo a piedi scalzi la miniera di zolfo. Eravamo in molti a lavorare in miniera, mezzo paese per dirla breve, certo il lavoro del minatore era proprio un brutto lavoro, ma che volete ci assicurava un pezzo di pane, solo così avremmo potuto sfamare i nostri figli. Eravamo costretti “mischineddi” (poveracci) a partire il lunedì mattina per poi tornare in paese il sabato sera. In mano tenevamo un la gavetta (contenitore) di alluminio, al cui interno, le nostre donne avevano messo una serie di pietanze che dovevano assicurarci un’alimentazione dignitosa durante la settimana.
Avremmo dormito come sempre accampati alla meglio nella stessa miniera, distesi per terra s’intende, sopra qualche straccio rimediato alla meglio, senza alcuna comodità.
E ancora all’alba facevamo ingresso nella miniera, il buio netto e intenso ci rendeva per un momento ciechi, ma raggiunto un largo, ci dovevamo spogliare nudi, rimanendo con le sole mutande, che volete, faceva troppo caldo, e più si scendeva e più si soffocava, e man mano scendevamo le lanterne ad acetilene (“citalena”) a stento riuscivano ad illuminare gli stretti cunicoli, ad ogni passo, ahimè il timore era quello di sentire l’antimoniu (idrogeno solfarato) che ci avrebbe fatti saltare all’aria anche solo con una scintilla, e così ogni tanto cercavamo l’un l’altro i nostri sguardi, e in silenzio, senza spiccicare una parola, cercavamo la forza per andare avanti. La ventilazione, più si scendeva più era difettosa, la poca aria che riuscivamo a respirare era rarefatta e i nostri respiri diventavano sempre più affannosi.
Io ero quello che gli altri chiamavano “picconiere“, il mio compito era quello di trovare i filoni zolfiferi e procedere all’escavazione, e colpo dopo colpa nella roccia, riempivamo, con il sudore delle nostre fronti, le“truscie” (contenitori di iuta) con lo zolfo che avevamo picconato, che poi sarebbe stato trasportato a spalla dai “carusi” (ragazzi) dalle profondità della miniera all’esterno, ragazzini ancora piccoli per intenderci, dagli undici anni in su, che riuscivano incredibilmente a trasportare carichi dai 30 agli 80 Kg.
Ma, chi erano questi carusi ? Bambini costretti dall’indigenza economica delle loro famiglie a lavorare come schiavi nelle miniere di zolfo. Lo stesso termine “carusi” pare derivi dalla consuetudine di rasare completamente la testa degli stessi, per le condizioni di estrema sporcizia nelle miniere: tale taglio di capelli veniva chiamato appunto “tagghiu carusu. “
E anche se era illegale impiegare nel lavoro manuale un minore di 12 anni in quanto la legge lo proibiva, tuttavia, questa disposizione veniva largamente disattesa a causa della miseria nella quale vivevano le famiglie contadine. Poi, c’erano gli “spisalora” (manutentori nelle gallerie) e gli “acqualora” (che si occupavano delle acque affioranti nelle gallerie).
Ma cosa c’era dentro la gavetta? Non potevano mancare le sarde salate, almeno una decina, che poi a tempo debito, risalendo su nella bocca della miniera, avremmo come sempre messo a sciogliere dello zolfo nell’avite (contenitore di zolfo), che appena liquefatto e ancora bollente ci sarebbe servito per immergere e cuocere in un solo istante le sarde ancora salate, trattenute com’erano da un fil di ferro, andavano giù, in un solo boccone, una dietro l’altra.
“Mentre ancora lo zolfo è liquido e ardente della gavità gli zolfatari usano cuocere certi loro cibi: e particolarmente le sarde salate. Basta, tenendole per la coda, calarle nello zolfo per un momento e ne escono rivestite di una crosta di zolfo. Sgranocchiata la crosta, ecco la sarda cotta: di un sapore che un po’ tiene di certi pesci affumicati ma con in più il sentore dellozolfo,piacevolissimo.”
Dal mare alla terra, per intenderci. Così come immancabili erano nella gavetta le melenzane “ingessate”, murate insomma. Le nostre donne incidevano una melanzana, inserivano in ogni fessura, trito di prezzemolo ed aglio, pecorino siciliano e cosacavaddu, puntine di sarde salate, e trito di olive nere, e per finire una bella manciata di pepe nero, dopo di che, le cuocevano in un pentolino con un filo di olio d’oliva e un pò di pomodori tagliuzzati, le portavano in cottura e le lasciavano raffreddate. Le coprivano con delle foglie di fico e le legavano a dovere con fili di raffia. Poi le poi le muravano con un impasto di gesso e zolfo e le facevano rassodare. Era questo un ottimo contenitore termico che assicurava la salubrità della stessa melanzana, consumata da noi minatori anche a metà settimana.
Calogero Matina Kalos


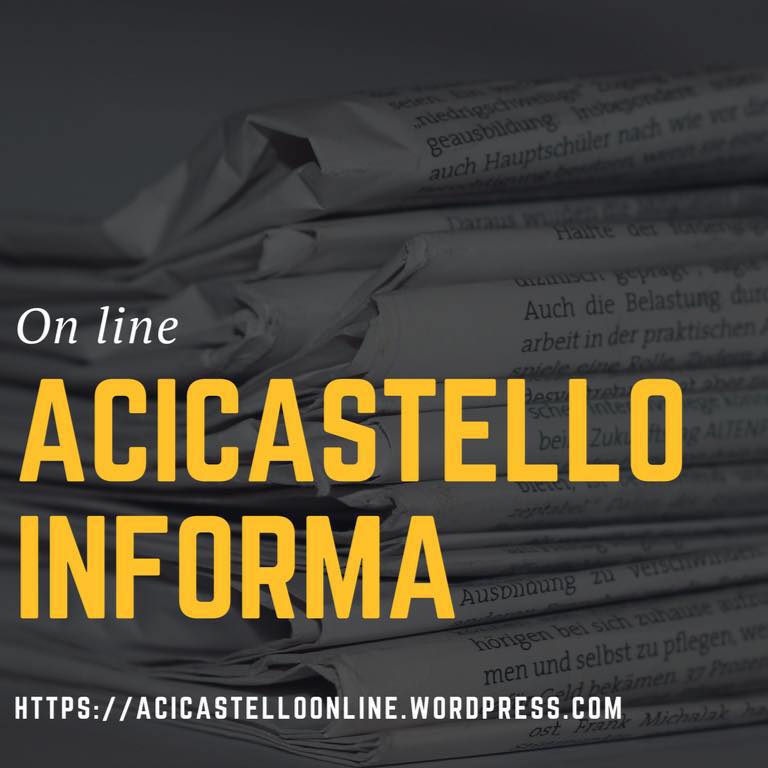




Lascia un commento