L’ARTE DEL MICHELASSO, CUCINA BARONALE SICILIANA
Siamo nella Sicilia del tardo Ottocento quando ancora regnava il “maggiorasco”, per dirla breve, abitudine passata da padre a figlio in cui il patrimonio familiare poteva essere ereditato solo dal figlio primogenito.
Vi chiederete che fine facevano i fratelli minori? Non rimaneva loro che dedicarsi alla carriera ecclesiastica, che tanto monastica, detto tra noi, non era affatto. E proprio dentro ai monasteri, principi, conti e baroni, continuavano a nuotare nell’abbondanza senza alcuna privazione, insomma una vita degna del loro rango.
È proprio in questo periodo che si sviluppa la cucina siciliana dell’Ottocento, quella feudale per intenderci, anche detta baronale. Da un lato c’era la cucina dei grandi palazzi, con la sua ostentazione, e dall’altro la generosa cucina conventuale dei monasteri.
Anche nei monasteri, vista la possibilità economica, ci si poteva permettere un Monzù, una sorta di cuoco a tre stelle dell’epoca.
Ed è proprio a Catania, che si trova uno dei monasteri più potenti e ricchi di quell’epoca, quello di S.Nicola, la più grande abazia d’Europa.
Lo stesso Federico De Roberto nei “Viceré” offre un’immagine senza veli delle attività religiose, svelandocene i più arcani segreti:
“I monaci, cari miei, oltre a pregare, facevano l’arte di Michelasso: mangiare, bere e andare a spasso. Levatasi la mattina, scendevano a dire ciascuno la sua messa, giù nelle chiese, spesso a porte chiuse, per non essere disturbati dai fedeli; poi se ne andavano in camera a prendere qualcosa, in attesa del pranzo a cui lavoravano nelle cucine spaziose come una caverna, non meno di otto cuochi, oltre agli sguatteri.
Ogni giorno i cuochi ricevevano da Nicolosi quattro carichi di carbone di quercia per tenere i fornelli sempre accessi, e solo per la frittura il cellario di cucina consegnava loro, ogni giorno, quattro vesciche di strutto, di due rotoli ciascuna, e due cafissi d’olio: roba che in casa del principe bastava per sei mesi.
I calderoni e le graticole erano tanto grandi che ci si poteva bollire tutta una coscia di vitella e arrostire un pesce spada sano sano; sulla grattugia due sguatteri, agguantata circa mezza ruota di formaggio, stavano un’ora a spiallarvela; il ceppo era un tronco di quercia che due uomini non arrivavano ad abbracciare, ed ogni settimana un falegname, che riceveva quattro tari e mezzo barile di vino per questo servizio, doveva segarne due dita, perché si riduceva inservibile dal tanto triturare.
In città, cari lettori, la cucina dei Benedettini era passata oramai in proverbio; celeberrimo il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, gli arancini di riso grossi come un melone, o le immancabili olive imbottite, i crespelli melati, erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare; e poi gelati, per lo spumone, per la cassata gelata…”.
Calogero Matina Kalos


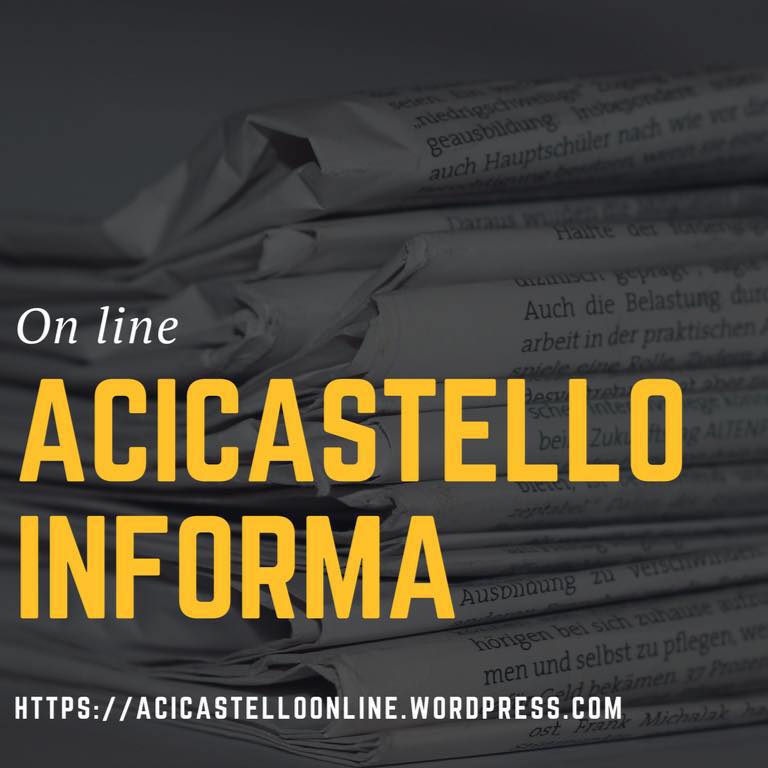




Lascia un commento